
Ligabue senza photoshop seduto sulla Royal Albert Hall
Sfida: ditemi almeno dieci artisti e/o gruppi italiani che siano effettivamente famosi all’estero. Diciamo, che possano fare sold out in un club di media grandezza, 700 posti, in una grande capitale europea. Avete trenta secondi. Via.
...
Avete detto Afterhours? Verdena? Marlene Kuntz? 99 Posse? Sud Sound System? Vinicio Capossela? Caparezza? Canzoniere Grecanico Salentino? Mi sa che avete detto bene. Sono tutti esempi di artisti nati nella Penisola che, all’estero, fanno vendere biglietti. “Ma Elia”, dice il vostro bambino interiore un editor di Noisey a scelta, pestando i piedi e mettendo su il nuovo LP collaborativo tra i Boris e Merzbow, “fanno tutti cagare!” Be', magari sì, fanno cagare. A voi. E chissà, forse anche a me. Ma non a un sacco di altra gente, che riempie i loro concerti a Parigi, Londra, Berlino, Bruxelles, Barcellona.
“Povero coglione”, ribattete in questo fantastico dialogo che sto usando come espediente narrativo per introdurre l’articolo, “ma tanto a vedere le band italiane all’estero ci vanno solo gli italiani!” E anche qua, nella maggior parte dei casi, non avete affatto torto. Ad esempio: secondo statistiche ufficiali, nel Regno Unito vivono più di 200.000 italiani ufficialmente registrati—tra cui l’autore di questo pezzo, che sta a Londra. Unendo le persone non registrate al totale, si arriva facilmente al mezzo milione di esseri umani, creando un bacino di potenziale utenza non indifferente per un promoter di concerti.
I macro-ragionamenti che possono scaturire da questo fatto sono due. 1) “Che figo, anche chi vive lontano da casa può andare a sentire la buona musica italian. E il tour è pure un’occasione per i gruppi di confrontarsi con nuove realtà, conoscere nuove persone, magari iniziare ad aprirsi nuove porte. Bene così, ragazzi.” e 2) “È una farloccata clamorosa: una band italiana che suona di fronte a un pubblico di italiani espatriati è solo un’espressione della triste provincialità che abbiamo nel sangue, non un segnale di successo dell'esportazione. È per cose come queste che la musica italiana resta derivativa e non riesce ad essere qualitativamente figa e competitiva a livello internazionale”.
Ora: è questione di punti di vista, e per oggi sospendiamo il giudizio. Siamo qui riuniti, anzi, per cercare di capire quali siano i motivi di questa polarizzazione dell’opinione riguardo al concetto dell’ italiano all’estero, ugualmente preso per il culo e glorificato ogni volta che lo si tira fuori—durante le conversazioni che facciamo all’aperitivo o in articoli sui siti del cazzo per gli italiani a Londra.
“Quando organizziamo il tour di un gruppo italiano non dovremmo guardare la cartina dell’Italia ma dell’Europa”, mi spiega Attilio Perissinotti, ex-Virus Promotion, ora patron di BPM Concerti e—per l’estero—TIJ Events. “A Parigi ci sono 200.000 italiani. A Londra ce ne sono 500.000. È più probabile che Il Teatro degli Orrori faccia sold out qua che in Friuli, no?” Da un punto di vista meramente economico, non fa una piega. Attilio ha iniziato a organizzare concerti all’estero quasi per sbaglio, nel 2008, per divertirsi e togliersi uno sfizio: “Avevo preso il Barfly, a Camden, per due giorni. Un martedì e un mercoledì. Ho fatto tre gruppi e tre gruppi, e l’ho chiamato The Italian Job.”
“C’erano i Casino Royale, i Tre Allegri, gli Hormonauts—che andavano fortissimo, soprattutto all’estero, dato che avevano un cantante scozzese.” Il risultato furono 200 persone a sera, un locale stracolmo e, qualche giorno dopo, una telefonata dal management di Vinicio Capossela. “In quel periodo, un promoter estero non avrebbe organizzato un suo concerto neanche con una pistola puntata contro”, mi dice. Di fronte al Barfly c’era un altro locale oggi defunto, il Dingwalls: Attilio pagò qualche centinaio di sterline, prese il locale, e organizzò la cosa. Sold out, 600 persone. Poi una chiamata dall’entourage di Ligabue: due date al KOKO, altri due successi. “Ma non sarà mica che mi sono trovato un nuovo business?”, mi racconta Attilio sorridendo.
Aprire una società nel Regno Unito non è affatto complesso, e fu così che nacque TIJ Events. Inizialmente, mi spiega Attilio, c’era il pensiero di allargare gli affari: non solo concerti ma magari una distribuzione, un’etichetta. “Poi ho detto, ma chi la compra ‘sta roba? Solo gli italiani. Facciamo solo i concerti, và. E in effetti è vero: facciamo concerti per gli italiani. Ma che male c’è? Ovvio che se Larsen suona a Cafe OTO di fronte a 150 inglesi sono felice, ma questi sono concerti di comunità. Uno dice, “Perché Caparezza fa sold out a Londra?” Perché ci sono 1350 pugliesi che vogliono andare a vederlo, semplicemente. Gli spagnoli fanno la stessa, cosa, come anche i polacchi.”
Come capita, però, che alcuni artisti riescano effettivamente a sviluppare un seguito oltre confine? Un esempio è il sopracitato Capossela, che ha trovato una chiave nella percezione del suo prodotto come world music: così come noi possiamo trattare i Songhoy Blues in questa chiave, MOJO può dargli il disco del mese e un centro culturale di prim’ordine come il Barbican Centre può prendersi bene e presentarlo sotto una chiave internazionalista. In questa diversità percettiva sta, anche, l’effettiva possibilità di costruzione di una propria dimensione extra-italiana.
I risvolti positivi degli eventi che organizza, mi dice, sono tanti. Da un lato, c’è il classico ma sempre valido angolo della crescita artistica e mentale dei musicisti coinvolti. Ad esempio “un gruppo inglese che suona al Garage di Islington prende l’incasso, non un cachet fisso. Questo, da noi, quasi non esiste.” C’è inoltre un discorso di tempistiche e di professionalità: “Scommetto che vai più a concerti dal lunedì al giovedì che nel weekend”, mi dice. Glielo confermo. “Perché da noi si suona solo il venerdì e il sabato, a partire dalle undici e mezza, mezzanotte. E quindi le band italiane non sono generalmente abituate a fare anche solo cinque concerti di fila, mentre un gruppo inglese ne fa anche trenta in trenta giorni. Poi, iniziare un concerto alle sette e mezza da noi è improponibile. Anche se lo fai iniziare alle nove e mezza la gente arriva incazzata. Però se ne va felice, perché ha tempo di tornare a casa a un orario umano.”
A questo si affianca anche una diversità nei ruoli della promozione musicale: “I locali, qua, non sono promoter. Affittano la sala, non fanno concerti. La Union Chapel costa 2200 sterline, per dire. Che sembra una cifra alta, ma non lo è. Impianto, audio, luci, tecnici, sicurezza, cassa: è tutto compreso nel prezzo.”
L’approccio di Attilio è quindi sul lato propositivo dello spettro: anche se ammette candidamente di non essere fan di parte della musica che promuove, e che il rock cantato in italiano non lo ha quasi mai convinto, TIJ fa comunità: offre agli espatriati la possibilità di un breve ritorno alle origini, accoglie un bisogno di italianità e lo soddisfa in un’ottica imprenditoriale. Ma lo fa affiancandoci un’enorme lucidità sullo stato di cose della musica italiana in un contesto europeo, declinato nella diversificazione delle proprie promozioni. “Io sono stato uno dei primi italiani a girare le fiere di settore in Europa”, mi spiega Attilio, descrivendo un mondo ambivalente. Eventi come il [defunto, nda] PopKomm di Berlino, il PrimaveraPro di Barcellona, l’Eurosonic di Groeningen o il MAMA di Parigi sono convention in cui gli addetti ai lavori del settore musicale si incontrano con l’obiettivo esplicito di fare rete. Ovviamente non solo solo le agenzie di booking a presentare i propri stand: sono anche, e soprattutto, i vari Music Export Office europei. Ma che cos’è un Music Export Office?
Detto terra terra: un Music Export Office è un ufficio statale che aiuta i gruppi della propria nazione a suonare oltre confine. Ce ne sono una caterva: quello islandese è grossissimo, così come quello austriaco, tedesco , francese, scandinavo. In Spagna ce ne sono tre: uno centrale, uno in Catalogna e uno in Galizia. Tutti si ritrovano ogni anno in fiere internazionali, in cui avvengono scambi di artisti, si instaurano collaborazioni, vengono fatti affari. Attilio mi racconta di avere organizzato concerti in festival europei per un sacco di artisti italiani in occasioni simili, e come controparte mi porta la testimonianza di uno stand della RAI con annesso concerto dei semi-inesportabili Baustelle a suonare dal vivo e di un epico baraccone della SIAE (“Presente il classico stand da ricchi?”) snobbato da tutti in quanto privo di informazioni effettive sulla promozione di artisti nostrani. E stop, perché in Italia un Music Export Office non è mai esistito.
Almeno, non è mai esistito a livello nazionale: se consideriamo le regioni, dobbiamo allora necessariamente parlare dell’esperienza di Puglia Sounds. “Fondamentalmente l’obiettivo è quello di creare azioni di sviluppo del sistema musicale pugliese”, mi spiega Antonio Princigalli, coordinatore del progetto, unica realtà italiana di derivazione pubblica atta esclusivamente alla promozione internazionale di un nostro prodotto musicale. “Consideriamo la musica come una filiera complessa fatta di festival, artisti, case discografiche, imprese”, mi dice. Si parla di “valore culturale”, ma anche di “valenza imprenditoriale”: la musica pugliese come comparto produttivo, insomma. E in quest’ottica, l’esportazione diventa fondamentale.
C’è una preoccupazione legittima che potrebbe venirvi in mente, a questo punto: dato che siamo un paese in cui il ministro della cultura fa gli shoutout a Zalone, chi garantisce che un’agenzia del genere non ricopra di soldi, boh, La scapigliatura? (Fine del dissing, sorry). Qua ritorna il caro vecchio valore della tolleranza: per quanto sia sano e giusto spingere per una cultura, e quindi anche musica e critica, italiana come struttura effettivamente tesa ad un arricchimento dei propri fruitori, nessuno può effettivamente decidere in cosa questo arricchimento consista. Quindi, per quanto potrebbe piacervi, non potrete mai imporre alla gente di non ascoltarsi più la roba di Garrincha, i canti degli alpini o la pizzica dub. E, ugualmente, nessuno impedirebbe a questi di prendersi soldi statali per suonare all’estero: questo non significa però che chi davvero ha un’attrattiva e un pubblico internazionale (un Donato Dozzy, un Teho Teardo) non possa effettivamente goderne lo stesso.
Mi spiego meglio: così come i Marlene Kuntz suoneranno sempre di fronte a un pubblico quasi interamente italiano, anche in Norvegia ci sarà una band alt-rock famosa che canta in norvegese e quindi con zero possibilità di sviluppare un pubblico estero. Il trick, qua, sta nel modo in cui un Music Export Office (teoricamente) funziona. Antonio me lo racconta nel dettaglio: “Da un lato lavoriamo sulla mobilità artistica, creando relazioni con festival, operatori, associazioni internazionali, creando una situazione a chilometro zero.” In poche parole, Puglia Sounds finanzia i viaggi – ma non con la benda sugli occhi. “Noi non entriamo nel mercato, il mercato si deve fare per conto proprio. Se, anche in virtù delle nostre sollecitazioni, il festival X ritiene utile e interessante programmare artisti pugliesi, questo li sceglie e noi contribuiamo perché la cosa accada”. Un’altra via percorribile sono i bandi pubblici: “Chiediamo agli operatori, alle agenzie italiane ed internazionali che tipo di programmazione di artisti pugliesi intendono fare nei 6 mesi successivi. Loro ci mandano le loro proposte, in cui non ci dicono semplicemente ‘Vogliamo fare 6 date della band x nel luogo y’. Ci devono dire come intendono fare promozione, in quali luoghi, se i musicisti ci sono già stati, quali sono i risultati e le evoluzioni di questi gruppi in questi singoli paesi”. A valutare l’efficacia della proposta è poi una commissione dedicata, e solo dopo parte il sostegno economico.
A quanto mi dice Antonio, i musicisti che dati alla mano – e quindi oggettivamente – hanno più saputo capitalizzare sulle opportunità causate dal loro essere pugliesi sono il Canzoniere Grecanico Salentino (che, zitti zitti quatti quatti, fanno tour americani con biglietti a 15/20 dollari in locali sul migliaio di posti e si beccano le rece sul Guardian, i Kalàscima, i musicisti jazz Nicola Conte e Gianluca Petrella – e Populous. Morale: possono anche farvi cagare la musica tradizionale, la taranta e il jazz, ma se comunque vi prende bene la musica del caro Andrea Mangia (come, personale opinione, dovrebbe essere) ci guadagnate comunque. Perché proprio loro, però? “Usano linguaggi indubbiamente più internazionali”, dice Antonio, “Vale molto quanto sei capace di creare opportunità.” Non molto diversamente dalle logiche del lavoro culturale contemporaneo: se riesci a conoscere gente e continui a proporti, se sei bravo e con un po’ di culo, magari ce la fai anche a lavorare con qualcosa che ti piace. Non è solo meritocrazia, ma nella musica il merito è – fortunatamente o meno – soggettivo.
“Quanti concerti di Bregovic, o dei Daft Punk, hanno solo pubblico serbo o francese?”, mi chiede Antonio quando gli chiedo della nazionalità delle persone che si presentano ai concerti che Puglia Sounds sponsorizza. “Non c’è niente di male se faccio 50 date all’estero e queste sono piene di cittadini italiani. E se sono a Londra è probabile che mi porti il mio amico di casa o di studi che è inglese, pakistano o altro. Ma se io esporto il vino pugliese, che lo comprino gli italiani o che lo comprino i locali, qual è la differenza?” Da un punto di vista imprenditoriale e di guadagno nazionale, nessuno. Da un punto di vista artistico, forse qualcosa cambia: ma, penso, non tanto da minare il senso dell’iniziativa Puglia Sounds. D’altro canto, un prodotto identitario come può essere quello del Canzoniere Grecanico Salentino avrà sempre e comunque la sua audience, fatta di pugliesi e gente interessata alla world music, ovunque si trovi nel mondo, che ci piaccia o no.
Resta che l’assenza di un Music Export Office danneggia la musica italiana in toto anche solo perché ci abitua a lavorare in modo diverso rispetto allo standard europeo. In un contesto privo di risorse, il cambiamento sta nella volontà del singolo, o dei singoli, di raggiungerlo – e anche da un po’ di casualità, che non fa mai male. Ed esempi virtuosi ci sono: abbiamo quindi parlato con un paio di soggetti italiani che non si pongono come obiettivo i-concerti-per-gli-italiani-all-estero, ma la pura promozione di artisti italiani in un contesto internazionale. Nello specifico Club to Club, tramite il progetto the Italian New Wave, e due agenti indipendenti stazionati a Berlino, Anita Richelli ed Ercole Gentile.
“Conoscendo il sistema italiano, e il sistema-musica italiano, non ho molta fiducia sull’utilizzo meritocratico di eventuali fondi”, mi dice Guido Savini di Club To Club al telefono, direttamente da un affollato bus torinese – “Chiaramente fa sempre ridere dover dire a un olandese che, in Italia, non ne abbiamo.” Gli ho appena chiesto che cosa succederebbe secondo lui se esistesse un Music Export Office italiano, e la sua opinione non è delle più speranzose. Ma lo è senza particolari lamentele, anzi: “Ovviamente parliamo con un sacco di altri festival con l’obiettivo di portare a suonarci artisti italiani, e a un certo punto negli scambi di mail arriva sempre la domanda: ‘Ok ottimo, riuscite a trovare dei fondi?’ E ogni volta dobbiamo spiegare che siamo l’unico paese in cui questi fondi non esistono. In questo momento li stiamo mettendo noi.”
E C2C fa bene a sentirsi il cuor leggero, dato che è una delle pochissime realtà di organizzazione eventi effettivamente internazionale del belpaese. Nello specifico, Guido si occupa del progetto The Italian New Wave (su cui abbiamo appena pubblicato un documentario, piattaforma di promozione dedicata a musicisti elettronici italiani.) “Perché C2C sia quello che vuole essere per la scena italiana, deve per forza pensare al territorio nazionale” mi spiega Guido. Il nome dell’iniziativa viene da un tweet di James Holden che, durante un set di Vaghe Stelle all’edizione 2010 del festival, commentò con un “Qualcosa sta succedendo in Italia: l’Italian New Wave”. E quello fu il punto di partenza di un lavoro costante di promozione, fatto con criterio. Un’esperienza che può servire da esempio perfetto per dimostrare la realtà dietro al luogo comune per cui noi italiani, quando siamo senza risorse, ci sbattiamo e magari qualcosa di (molto) bello lo tiriamo fuori comunque.
“Ogni anno il festival porta giornalisti da tutto il mondo a Torino, e una domanda fissa è ‘Parlateci dei vostri artisti locali’. Un sacco di loro, se escono, escono su canali molto underground e non vengono promossi sul territorio nazionale. Abbiamo quindi pensato di promuoverli sia all’estero che in Italia”. Come? Come funziona nel mondo dei media contemporanei, tramite contatti stretti negli anni. A forza di proporre eventi e di invitare artisti sempre un po’ più famosi, C2C è riuscita a stipulare accordi di promozione con realtà coi controcoglioni: “A dicembre 2014 è stata fatta uscire una compilation su Bleep [piattaforma di proprietà Warp Records, nda], con una serie di inediti degli artisti della scena, che è stata poi seguita da una stessa iniziativa per la Germania e la Polonia.” Inoltre, da anni C2C organizza eventi a Londra interfacciandosi con realtà locali come il Field Day Festival, inizialmente affiancando artisti e internazionali culminando, l’anno scorso, con uno showcase di Ninos Du Brasil, Vaghe Stelle e Not Waving sponsorizzato da un centro culturale prestigiosissimo come il Barbican. Risultato? Ce lo dice Guido: “Il Guardian è venuto al festival e, invece di fare la recensione del concerto di Thom Yorke, ha fatto un pezzo proprio sugli artisti italiani”.
Contatti, dicevamo: oltre a quelli ricavati per via digitale e/o organizzativa, chiedo a Guido che cosa ne pensa degli eventi di networking per gli addetti ai lavori di cui abbiamo parlato sopra. La sua opinione è che questi non siano il punto focale della questione: “Sì, siamo sottorappresentati. Ma lo siamo il giusto per quanto possa essere rilevante il mercato italiano.” D’altro canto un promoter, che “acquista contenuti musicali e li porta nel proprio paese”, deve stare attento a non impelagarsi in situazioni rischiose per fare bene il suo lavoro: e allora un’Italia disabituata al modus operandi europeo si trova inevitabilmente messa da parte. Il contributo di realtà come Club to Club diventa quindi fondamentale per tenerci all’interno di un’ideale mappa della cultura europea: “Negli anni siamo riusciti a metterci al livello dei più grandi festival. Abbiamo agenzie che ci scrivono e ci danno la priorità per certe proposte. Di rimando, noi proponiamo artisti italiani. È questo il nostro gioco.” L’elettronica di casa nostra ringrazia, e chissà cosa sarebbe successo se, 15 anni fa, altre realtà concentrate su altre forme musicali avessero preso forma sul nostro territorio.
Quando trattano artisti italiani, Anita Richelli ed Ercole Gentile organizzano un concerto ogni due, tre mesi. Entrambi vivono a Berlino e sono semi-indipendenti nelle loro attività: Anita lavora come agente all’interno della tedesca Paper & Iron Booking, che le lascia libertà di selezione riguardo agli artisti che promuove; Ercole, invece, procede in modo indipendente e, tra i suoi vari progetti, gestisce anche le date tedesche di qualche gruppo nostrano. Lei ha lavorato con Any Other, C+C = Maxigross, His Clancyness, Be Forest e Iosonouncane; lui con Verdena, Dente, Zen Circus, Paolo Benvegnù, Lo Stato Sociale e molti altri. Nel primo caso, nomi più particolari – nel secondo, realtà più assimilabili alle logiche concerti-per-espatriati che abbiamo trattato con Attilio di TIJ. Entrambi, mi pare, sono esempi di come la promozione della musica italiana all’estero ricada sulle spalle di singoli, e di come le reti di collaborazione nascano esclusivamente dall’iniziativa personale.
Ercole, ad esempio, mi parla di una nascente partnership tra locali gestiti da italiani tra Berlino, Parigi e Bruxelles: “Organizzando cose simili e con uno stesso target è a favore di tutti riuscire a dare agli artisti l’opportunità di fare più date possibili per cercare di ammortizzare i costi.” Chiaramente questo è fattibile principalmente per proposte in cui non serve un grosso palco, e quindi cantautori. Quando si ampliano le dimensioni dei locali, la situazione è simile a quella londinese: “Spessissimo andiamo a biglietti e non a cachet fisso. È come se facessimo una coproduzione direttamente con la band. A fine serata, tolte un tot di spese, si divide l’utile tra l’organizzazione e il gruppo”. Perché questo abbia senso è necessario un lavoro preparatorio sotto forma di una promozione locale, che a volte Ercole gestisce personalmente e ha visto avere maggior riscontro di publico con gruppi come Calibro 35, Mellow Mood e Julie’s Haircut – proposte non legate ad un cantato in italiano e quindi probabilisticamente più adatte all’esportazione, ma anche supportate da un efficace lavoro di ufficio stampa locale e nato dalle stesse band.
Ma la lingua del cantato, secondo Anita, non è fondamentale quando si parla di esportazione musicale: “L’internazionalità del progetto non esiste, non è legata al prodotto musicale di un artista ma al suo modo di ragionare. Tutti i gruppi italiani che stanno avendo un po’ di successo all’estero ci hanno investito tanto tempo andando a suonare in giro, o hanno gente che ha investito su di loro mettendoci uffici stampa e voglia di portarli ai festival importanti”. Se questo non accade è per una generale disabitudine a logiche organizzative estere: scrivere a un locale tedesco non porterà nulla a una band italiana, mentre un contatto con una band, un promoter o un collettivo locale porterà con sé sicuramente più probabilità di collaborazione – confermando quello che ci diceva Attilio Perissinotti su Londra.
“Mi dispiace che ci sia pochissimo scambio tra zone limitrofe, e per l’Italia parlo di Svizzera, sud della Germania, Austria, Slovenia, Croazia, Serbia e Macedonia”, enumera Anita. “Quando mi metto a lavorare con un promoter austriaco, questo magari conosce benissimo i miei amici e conoscenti di Belgrado, ma neanche un italiano. Non è che ho statistiche alla mano, ma in questo ambiente ci si conosce tutti. E quindi è un po’ triste.” La stessa distanza si percepisce agli eventi di settore: Anita mi parla poi del MENT, un semi-neonato incontro a Lubiana, cinque ore di macchina da Milano: “Le uniche due italiane eravamo io e Katia di Estragon, che aveva partecipato un anno prima con i Joycut. Io quest’anno ho portato gli Any Other. Se sei del settore è una figata: conosci tantissima gente che lavora nei locali, nei booking, nei festival. Per una band deve essere invece un’opportunità, una scusa per promuovere un tour, un disco, trovare qualcuno che ti faccia suonare. Non è che un festival ti svolta la vita.”
In effetti, a pensarci, un’azione di spinta mediatica efficace è oggi molto importante per aumentare la probabilità dell’effettivo successo di un musicista. Pensiamo a Courtney Barnett, passata nel giro di un paio di EP a un esordio lodato in toto dall’intera stampa internazionale: “Dietro a lei c’è stato sicuramente un lavoro colossale di ufficio stampa”, mi dice Anita. Si apre quindi un altro versante della questione: quanto è importante il lavoro di un’etichetta e di un ufficio stampa nel creare richiesta per una proposta musicale italiana? Gli esempi europei non mancano: dalla Spagna vengono le Hinds, passate per Mom + Pop, Burger Records e Lucky Number, e i Mourn su Captured Tracks. I tedeschi Notwist sono usciti su City Slang, lo svedese The Tallest Man On Earth su Dead Oceans: tutte label fortemente internazionali e a stretto contatto con i grandi tastemaker americani alla Pitchfork e Stereogum.
“Se fossi un’etichetta internazionale, che band italiana andrei a scritturare?”, chiede giustamente Anita senza sapersi dare una risposta. E continua: “Torno a dire, se fai il concerto per gli italiani a Berlino solo per gli italiani a Berlino e non cerchi di fare contatti, entrare in nuovi contesti, nessuna etichetta ti troverà mai.” E quindi la capacità di aggancio, la buona conoscenza dell’inglese, l’apertura a una socialità internazionale diventa motivo di merito ed effettiva porta d’ingresso ad un’audience iper-italiana. Basta chiederlo a band più piccole, che spesso fanno emo, HC, punk o math rock, abituate a fare tour in giro per il mondo con la semplice forza della collaborazione: ricordo i Verme in tour Inghilterra con i Well Wisher, ad esempio, o le numerosissime sortite estere dei Valerian Swing culminate nella partecipazione ad ArcTanGent – festival maximo per chiunque ascolti le cose un po’ con le chitarrine tecniche un po’ con le melodie un po’ col casino un po’ con le grida.
Tutti i ragionamenti che abbiamo fatto finora vanno idealmente accompagnati da una certa onestà intellettuale da parte di tutte le persone coinvolte nel processo. In particolare, mi riferisco a quegli artisti la cui italianità è ragione principale del proprio successo di pubblico. Ma, prima che diate fuoco alle torce e tiriate fuori i picconi in una crociata contro eventuali sboroni internazionali, mi sembra corretto dire che la situazione non è, a mio avviso, affatto tragica. Mi spiego.
Se la band dei vostri amici sfigati che pensano ancora che il primo dei Killers sia un’influenza legittima da avere nel 2016 suonasse gratis allo Shacklewell Arms perché il loro batterista conosce la sorella del tizio che organizza i concerti lì e, tornata, si mettesse a scrivere sul suo Facebook (672 like) cose tipo “Thank you London! We had really fun! All our new fans are amazing!” [nda: scritto male apposta] potete tranquillamente incazzarvi. Ma facendo un po’ di ricerche sugli internets (che, come è sempre giusto ricordare, non sono altro che una serie di tubi), vi renderete conto che eventuali proclami entusiastici riguardo ad eventi simili sono mediamente limitati a testate la cui influenza culturale è (o è stata) praticamente inesistente.
Prendiamo questa recensione di Rockit dell’esordio degli Afterhours a Londra, organizzato da Attilio nel 2007. È un’opinione decisamente positiva, ma contiene frasi come “il numero di inglesi presenti impallidisce di fronte alla rappresentanza italiana” e “L’impressione è un po’ di aver visto un concerto ad Anghiari”. Questo pezzo di Indie for Bunnies sui Verdena del 2008 è praticamente un post da blog adolescenziale, e lo prenderò ad esempio di numerosissimi “articoli” su concerti di italiani all’estero la cui importanza culturale e influenza mediale è tranquillamente trascurabile dato che sono scritti con ‘sta fascinazione per il nulla cosmico da gente che a Londra ci va per farsi le foto al Binario 9 ¾ a King’s Cross, mangiare il Fish & Chips a Leicester Square e magari fermarsi a fare una fotina a Berwick Street e una al negozio delle M&M’s (autore dell’articolo qua sopra: sono sicuro che tu sia cresciuto da allora, non prenderla male se oggi ti ho usato per rappresentare il male).
La cosa cambia quando si parla di media generalisti? Leggermente, ma non abbastanza da gridare alle mani nei capelli. La sezione “cultura” della Repubblica o del Corriere non sono certo paragonabili a quelle del Guardian, e non credo che nessuna persona sotto i 40 anni con un minimo di sale in testa si sia mai detta “Oh, vediamo quali nuovi album da ascoltare mi propone il Corriere”. Che questo sia un problema è indubbio; ma penso che, allo stato attuale delle cose, un’evoluzione in senso effettivamente critico delle terze pagine dei nostri quotidiani e settimanali sia un’utopia – almeno finché un po’ di ‘sta gente non se ne andrà in pensione dalla vita.
Intanto, se Repubblica fa un’intervista a Caparezza sull’estero è normale aspettarsi una sua narrazione innocua e positiva, ma non mi pare che da nessuna parte – se non con qualche soffice auspicio – si parli di un suo effettivo pubblico estero. “Sono in milleduecento al Koko di Camden Town [...] Tutti paganti, non tutti italiani.” O ancora, “Sa che lì sotto [...] ci sono un venti per cento di inglesi, un trenta di varie nazionalità e un cinquanta di italiani in fuga dallo stivale.” Parliamo anche di pop: TV Sorrisi e Canzoni fa un bell’intervistone al Liga sul suo concerto alla Royal Albert Hall, ma lui liquida la domanda sul pubblico con un generico e onesto “Naturalmente la maggior parte dei presenti sono italiani ma, grazie a Internet, sono sempre di più quelli che ci seguono anche da altre parti d’Europa”. Insomma, niente di trascendentale.
La situazione che abbiamo delineato è in continua evoluzione, e piena tanto di punti problematici quanto di spunti virtuosi da cui imparare. Resta necessaria la presa di coscienza del nostro posto all’interno del contesto europeo: così come le generazioni passate hanno bloccato lo sviluppo di una promozione culturale degna di questo nome tramite decenni di Fininvest, magna magna ed agglomerati editoriali monopolisti, oggi la musica italiana cerca di sopravvivere in un contesto nazionale complesso e, spesso, scoraggiante. La ricerca di una finestra di salvezza nell’estero è quindi più che ragionevole, anzi: può essere la chiave per riuscire, piano piano, a poter ridurre sempre più la distanza che ci ha sempre tenuti qualche anno indietro rispetto a quello che succedeva oltreoceano, oltremanica e oltralpe. Ma è un gesto da fare con criterio – altrimenti possiamo continuare ad accontentarci di questo:
Disclaimer: abbiamo contattato anche DNA Concerti, che ha declinato la partecipazione all’articolo – “Pensiamo che non si abbia l’esperienza necessaria nel booking di italiani all’estero per poter dire qualcosa di davvero ponderato e concreto”. Altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di eventi che vogliano dire la loro possono contattarci tranquillamente.
Segui Elia su Twitter.

 Foto di Giuseppe Guglielmino, via
Foto di Giuseppe Guglielmino, via  Foto via
Foto via 
 Foto Anis Ali
Foto Anis Ali Foto Carys Lavin
Foto Carys Lavin Foto Carys Lavin
Foto Carys Lavin Foto via utente Flickr
Foto via utente Flickr  Foto via
Foto via 


 Non avevo torto.
Non avevo torto. 




 Un momento che ci eravamo persi, ringraziamo
Un momento che ci eravamo persi, ringraziamo 


 Il Giappone ha fatto tante cose belle per il nostro svago: Keiji Haino, i Pokémon, la rovesciata di Okazaki contro il Newcastle e Cooking With Dog, ad esempio. Metal Resistance, però, non solo entra in grande stile tra i grandi artefatti culturali nipponici; risolve, finalmente, quelle aspre lotte intestine che hanno impedito finora al metal di diventare IL genere musicale per eccellenza, e conseguentemente a Giuseppe Binetti di entrare a X Factor qualche anno fa. Non ci sono poser e believer, nel mondo di Su-metal, Yuimetal e Moametal – solo la tanto agognata fratellanza sonora che, morta la generazione di aironmeide, giudaspris e colleghi, impedirà al metal di tornare all’underground da cui venne generato quarant’anni fa, evitandogli di finire schiacciato dalla sua stessa incapacità di smarcarsi dalla mera imitazione di uno dei grandi modelli del genere. “Awadama Fever” c’ha un growling occulto che manco Panzer Division Marduk, “Road of Resistance” è praticamente un pezzo dei DragonForce (forse anche perché l’hanno scritta e suonata i chitarristi dei DragonForce), “KARATE” ti spara i breakdown djent tutti brachelarghe e gomiti in faccia, “Meta Taro” suona più epica di un ipotetico figlio bastardo tra i Manilla Road e i Cirith Ungol, “Sis. Anger” è la dimostrazione che gli Slayer avrebbero fatto meglio a sciogliersi dopo Seasons In The Abyss – tanto, qualche anno dopo, tre idol giapponesi sarebbero arrivate a fare quello che avevano sempre fatto, e a farlo meglio. Metal Resistance è il suono della vittoria: un’utopia crollata nella realtà, il ritmo pulsante di un lieto fine, la sicurezza di un futuro migliore.
Il Giappone ha fatto tante cose belle per il nostro svago: Keiji Haino, i Pokémon, la rovesciata di Okazaki contro il Newcastle e Cooking With Dog, ad esempio. Metal Resistance, però, non solo entra in grande stile tra i grandi artefatti culturali nipponici; risolve, finalmente, quelle aspre lotte intestine che hanno impedito finora al metal di diventare IL genere musicale per eccellenza, e conseguentemente a Giuseppe Binetti di entrare a X Factor qualche anno fa. Non ci sono poser e believer, nel mondo di Su-metal, Yuimetal e Moametal – solo la tanto agognata fratellanza sonora che, morta la generazione di aironmeide, giudaspris e colleghi, impedirà al metal di tornare all’underground da cui venne generato quarant’anni fa, evitandogli di finire schiacciato dalla sua stessa incapacità di smarcarsi dalla mera imitazione di uno dei grandi modelli del genere. “Awadama Fever” c’ha un growling occulto che manco Panzer Division Marduk, “Road of Resistance” è praticamente un pezzo dei DragonForce (forse anche perché l’hanno scritta e suonata i chitarristi dei DragonForce), “KARATE” ti spara i breakdown djent tutti brachelarghe e gomiti in faccia, “Meta Taro” suona più epica di un ipotetico figlio bastardo tra i Manilla Road e i Cirith Ungol, “Sis. Anger” è la dimostrazione che gli Slayer avrebbero fatto meglio a sciogliersi dopo Seasons In The Abyss – tanto, qualche anno dopo, tre idol giapponesi sarebbero arrivate a fare quello che avevano sempre fatto, e a farlo meglio. Metal Resistance è il suono della vittoria: un’utopia crollata nella realtà, il ritmo pulsante di un lieto fine, la sicurezza di un futuro migliore. 
 Boh, e dico BOH: sto progetto non lo capirò mai. Se io fossi nel loro, nel senso, se fossi un santo della musica, uno considerato un pioniere del mio genere di riferimento, uno che ha contribuito a crearlo per come è ora e/o ne ha aumentato pesantemente lo spettro di influenza ficcandoci dentro nuove idee rivoluzionarie… Dico, se io fossi uno così e mi mettessi assieme a un altro tipo così a fare un progetto che pure se ci conosciamo da venticinque anni non ne avevamo mai fatto uno assieme, dico, se io fossi così, ecco, se lo fossi, ecco… Direi al mio compare: “mo’ famo il cazzo che ci pare, ci facciamo venire le idee più folli della terra e sperimentiamo con tutto il materiale che abbiamo a disposizione, tanto ci importa na sega a noi, siamo gli dei della techno.” E invece no, cazzo: questo è già il secondo album in cui Juan Atkins e Moritz Von Oswald e dico JUAN ATKINS E MORITZ VON OSWALD ci consegnano una manciata di tracce di techno sì raffinata, sì godibile, sì lambita dalle profondità riverberose dell’uno e graziata dalla classe essenziale dell’altro ma prevedibile e PALLOSISSIMA. C’avessero messo un’idea… Una! Come cacchio facciano due teste così ad incontrarsi e tirare fuori il disco più generico e meno ispirato dell’anno non lo so. Ci sono a malapena due tracce in cui provano a usare ritmiche diverse: una mezza-breakbeat e e l’altra quasi-garage. Non ce la si può sempre prendere con la terza età, però loro potrebbero pure provare a essere meno anziani, diamine.
Boh, e dico BOH: sto progetto non lo capirò mai. Se io fossi nel loro, nel senso, se fossi un santo della musica, uno considerato un pioniere del mio genere di riferimento, uno che ha contribuito a crearlo per come è ora e/o ne ha aumentato pesantemente lo spettro di influenza ficcandoci dentro nuove idee rivoluzionarie… Dico, se io fossi uno così e mi mettessi assieme a un altro tipo così a fare un progetto che pure se ci conosciamo da venticinque anni non ne avevamo mai fatto uno assieme, dico, se io fossi così, ecco, se lo fossi, ecco… Direi al mio compare: “mo’ famo il cazzo che ci pare, ci facciamo venire le idee più folli della terra e sperimentiamo con tutto il materiale che abbiamo a disposizione, tanto ci importa na sega a noi, siamo gli dei della techno.” E invece no, cazzo: questo è già il secondo album in cui Juan Atkins e Moritz Von Oswald e dico JUAN ATKINS E MORITZ VON OSWALD ci consegnano una manciata di tracce di techno sì raffinata, sì godibile, sì lambita dalle profondità riverberose dell’uno e graziata dalla classe essenziale dell’altro ma prevedibile e PALLOSISSIMA. C’avessero messo un’idea… Una! Come cacchio facciano due teste così ad incontrarsi e tirare fuori il disco più generico e meno ispirato dell’anno non lo so. Ci sono a malapena due tracce in cui provano a usare ritmiche diverse: una mezza-breakbeat e e l’altra quasi-garage. Non ce la si può sempre prendere con la terza età, però loro potrebbero pure provare a essere meno anziani, diamine.























 Red Ronnie, il suo cagnetto Holly e un pacchetto di taralli.
Red Ronnie, il suo cagnetto Holly e un pacchetto di taralli. Red Ronnie e Lucio Dalla: fu quest’ultimo a far capire a Red che Prince era un genio. Prima di allora pensava con lungimiranza fosse un semplice emulo di Hendrix.
Red Ronnie e Lucio Dalla: fu quest’ultimo a far capire a Red che Prince era un genio. Prima di allora pensava con lungimiranza fosse un semplice emulo di Hendrix.





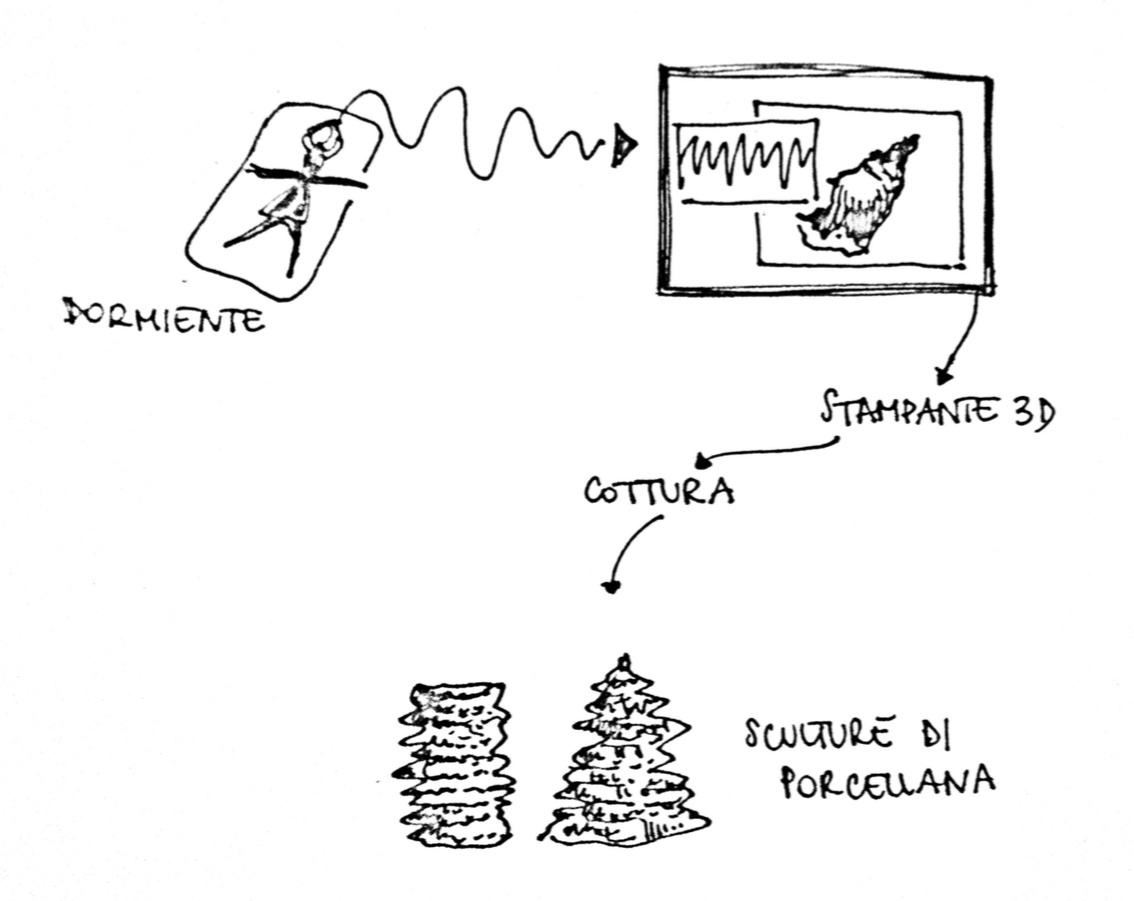





 Pauza (Foto via
Pauza (Foto via  Foto via
Foto via 





 s
s



